Belladonna, Stramonio e Giusquiamo, le erbe delle streghe
- Angelo Siviero

- 4 dic 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 17 gen

In Europa fino alla metà del XIX sec. la medicina ufficiale si era in parte riferita alla tradizione popolare. Ad esempio, la Farmacopea di stato del Granducato di Toscana, pubblicata nel 1789, elencava principi attivi animali e vegetali frequentemente riportati nei verbali dei processi per stregoneria. Dopotutto chi erano queste famigerate streghe? Nient'altro che delle cultrici di riti pagani e soprattutto delle sapienti conoscitrici di piante officinali e di veleni.
Non dimentichiamo che durante tutto il medioevo la cura nelle comunità rurali era affidata a loro e che a quel tempo erano in pochi a potersi permettere un medico. Un misto di magia, superstizione e conoscenza profonda delle arti naturali si mescolavano in queste figure, per lo più femminili, che a partire dal XVI sec. subirono tremende persecuzioni da parte della Chiesa in quanto accusate di eresia, magia nera e satanismo. La stregoneria è stata per secoli un argomento scomodo. Ultimamente si sono interessati diversi studiosi e ricercatori all'argomento. Con quasi totale unanimità si è convenuto che la profonda suggestione e l'isterismo evidenti in queste donne, così come documentato da molti atti dei processi dell'epoca, in realtà altro non era che la manifestazione di un effetto neurotossico provocato da alcune piante allucinogene: l'Atropa belladonna, la Datura stromonium e il Hyoscyamus niger. Queste sono le famose erbe delle streghe!
L'atropina e la scopolamina sono gli alcaloidi tossici contenuti in queste tre piante.
Entrambe bloccano in modo reversibile i recettori colinergici e in particolare impediscono l'interazione tra acetilcolina e i recettori muscarinici. Tra le due sostanze la scopolamina è la più potente. A dosi tossiche causa esaltazione, ottundimento psichico, senso di peso al capo. Ad occhi aperti si hanno le allucinazioni visive più disparate, anche di natura terrificante.
Essendo molto permeabile alla cute, la scopolamina in forma di estratto vegetale e opportunamente veicolata in unguenti, veniva spalmata dalle streghe su tutto il corpo e negli orifizi, al fine di ottenere l'allucinazione del "volo". A dosi efficaci invece la scopolamina genera secchezza delle fauci, secchezza oculare e bronchiale, blocco della sudorazione, midriasi, impedisce l'accomodazione oculare, rallenta la motilità intestinale, rallenta lo svuotamento vescicale, blocca la chinetosi detta anche mal di moto. Per questa ultima indicazione fino a poco tempo fa erano disponibili in commercio dei cerotti a base di scopolamina da applicare sul retro del padiglione auricolare. Con le nuove tecniche di veicolazione topica dei principi attivi è possibile riprodurre tali cerotti in farmacia partendo da ricetta magistrale e preparando un gel a base di Plo (Pluronic lecithin organogel) che permette di veicolare un'ampia varietà di principi attivo ottenendo un assorbimento transdermico.
Estratto da Farmacista33 del 12 febbraio 2016




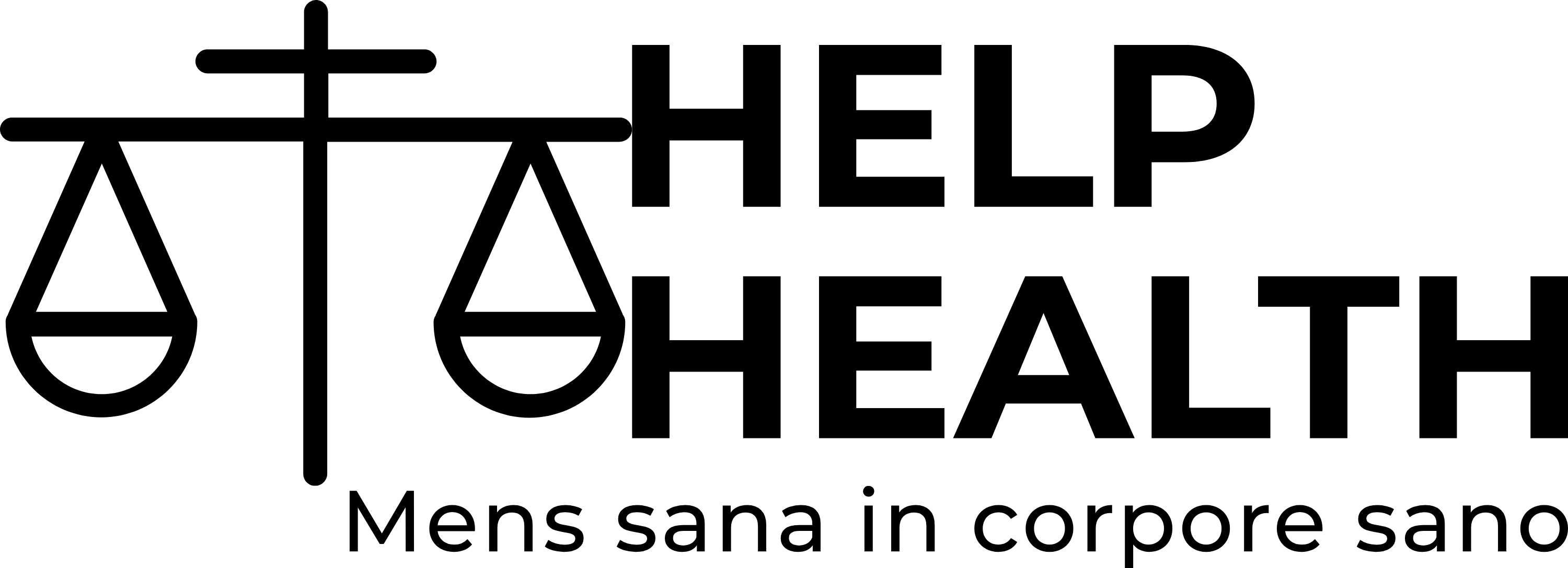
Commenti